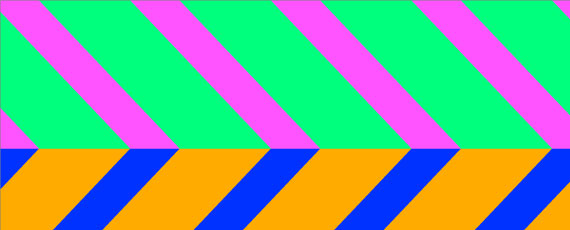
Oggi, con la feroce recessione economica che sta mettendo in crisi anche i brand più blasonati, Gaetano Grizzanti ci fornisce una chiave di lettura utile per capire cosa vuol dire per le aziende evolvere “da marchio a marca”. In questa intervista, alcuni spunti utili per ottimizzare le politiche di branding e navigare al meglio nelle acque agitate della nostra economia.
Nel suo recente libro “Brand Identikit”, edito da Fausto Lupetti, ripercorre la storia di venti marchi di noto valore. Quali sono, secondo lei, gli elementi comuni che li contraddistinguono come brand di successo?
Se escludiamo le realtà diventate brand grazie al prodotto - in passato è stato sostanzialmente così -, i marchi che in qualche modo si sono comportati da vere marche sono quelli che sono riusciti a imporre un concetto che, appunto, va oltre il prodotto. Lì si evince il vero branding e constatiamo che le aziende riuscite in questa evoluzione godono di lunga vita. Non solo i livelli di notorietà, ma la preferenza e la qualità percepita dal consumatore, l’immagine, il prestigio, la desiderabilità, l’appeal, sono gli elementi che connotano un brand di successo. Nel terzo capitolo di “Brand Identikit”, infatti, raccolgo, descrivo e commento la storia di venti marche riconosciute tra quelle più rappresentative dal punto di vista del branding a livello globale. Una selezione utile per evidenziare quelle realtà che nel tempo sono state in grado non solo di “performare” il proprio marchio in una marca ma che, di fatto - alla luce di queste testimonianze - hanno definito i paradigmi del branding. Oggi è quindi una vera e propria disciplina, formatasi grazie allo studio di questo tipo di fenomeno, dopo più di un secolo di marchi, con la sua metodologia, la sua tecnica, le sue casistiche. Ovviamente, per un’azienda di oggi interessata a costruire un brand, non si possono seguire le logiche con cui l’industria di marca ha costruito il suo successo nel passato, per le costanti e dinamiche evoluzioni in atto, però è possibile attingere dalla storia per acquisire le basi concettuali e cognitive.

Il valore di un marchio è soggetto a fluttuazioni continue. Come può essere messo in sicurezza?
La variabilità è una caratteristica precipua di questi tempi. Ma un brand, se gestito correttamente, vale più di un titolo di Borsa… si pensi a Coca-Cola, Ferrari, Apple e la lista potrebbe essere lunga. Il vero problema nasce dal modo con cui oggi si fa brand management, cioè come si gestisce questo valore, questo asset, oggi fondamentale per un’azienda. E lo possiamo riassumere, dando qualche consiglio: evitare di perdersi dietro le mode, atteggiamento peraltro utile anche per resistere agli attacchi di congiunture difficili come questa; mantenere un approccio sempre coerente con l’identità della marca. Per quanto riguarda l’aspetto economico, oggi sul mercato sono presenti molte aziende con gli asset intangibili separati dove far confluire gli investimenti legati al marchio, consentendo così una più razionale e finanziaria capitalizzazione.
Durante la “Sustainable Brands Conference”, svoltasi a Londra a fine novembre, il tema principale è stato “Come possono i brand spostare il comportamento dei consumatori verso un atteggiamento eco-attento”. Qual è il suo pensiero in proposito?
Sicuramente il tema della sostenibilità è molto attuale. Oggi un brand deve essere allineato a queste eco-tematiche perché è giusto che lo sia, altrimenti sarebbe un outsider anacronistico. Bisogna però stare attenti: a mio avviso, per un’azienda, non è sufficiente sostenere estemporaneamente una qualche iniziativa ambientale, sociale o altro legata alla sostenibilità. La vicinanza ai temi sociali, alla tutela dell’ambiente, ai problemi riguardanti le minoranze, l’infanzia ecc., devono far parte del Dna di un brand moderno. Si deve parlare quindi di un processo strategico e non tattico, come invece a volte abbiamo visto negli ultimi anni.
Nella grande distribuzione imperversa la guerra dei prezzi. Le aziende e i marchi più noti, a suo avviso, sono coscienti di dissipare i valori costruiti in anni di investimenti in comunicazione?
Questo periodo recessivo fa fare ai brand cose anche un po’ pericolose. Si nota da una parte un certo tipo di allineamento al contesto difficile nel quale le aziende si trovano a competere, e ciò può pensare che sia giusto operare in questo modo, visto il drammatico calo dei consumi e quindi del fatturato. Probabilmente il problema non riguarda come adottare politiche promozionali di particolare aggressività, ma quanto gestirle. Oggi un brand può anche fare un’operazione di “taglio prezzi” o un “concorso a premi”, ma deve farlo in un modo ben congeniato, rispettando sempre il suo posizionamento e il suo vissuto. Il rischio è elevato: con operazioni non coerenti si può mettere in predicato il valore di un brand. Sono d’accordo sulle operazioni promozionali, ma eseguite solo nel modo giusto, seguendo delle logiche motivate.
Anche le marche commerciali sono un brand per la grande distribuzione?
Assolutamente sì. Anzi, il fenomeno è sempre più consolidato. Un’insegna distributiva oggi è un brand a tutti gli effetti e fa da garante a qualsiasi tipo di offerta. Di conseguenza, per certi versi, possono anche giocare meglio la partita della convenienza. A maggior ragione i brand più “tradizionali”, obbligati a rispettare il loro posizionamento, hanno maggiori difficoltà a rispondere e ad assecondare l’area di business coperta dalle marche commerciali.
Però il consumatore sembra volere qualche cosa in più da un prodotto di marca…
Probabilmente oggi si deve costituire una presenza maggiore nell’interconnessione con il proprio cliente. Il brand deve farsi sentire più vicino, ingaggiando maggiormente i problemi del consumatore, colloquiare di continuo e mantenere aperti tutti i canali di contatto con il suo target, senza mai operare con atteggiamento arrogante o distante.
Lei ha una sua teoria del “marchio perfetto” in tempi di recessione economica?
In questo 2012 ho visto un fenomeno interessante: molte realtà aziendali stanno operando dei forti cambiamenti e contestualmente stanno facendo molta autocritica. Questi cambiamenti sono orientati a individuare un discorso di marca più profondo rispetto al passato. Ancora oggi alcune aziende pensano al prodotto come alla soluzione di tutti i problemi. Il prodotto, ovviamente, deve essere performante e deve avere le sue leve di differenziazione rispetto alla concorrenza, deve mantenere una qualità sufficiente, ma le sue caratteristiche intrinseche e funzionali oggi sono purtroppo un prerequisito. Il peso dell’immagine diventa, invece, basilare ed è il plus discriminante in un “marchio perfetto”, ma non è facile gestirlo. Quindi, a mio avviso, bisognerebbe creare dei reparti di ricerca e sviluppo anche in ambito branding, come del resto esistono all’interno delle aziende nella parte industriale. Un reparto R&D non solo per lavorare sull’innovazione e lo sviluppo del prodotto, ma del brand, oggi primo prodotto di un’azienda e suo vero “core business”.
I marchi di grande rinomanza, spesso posseduti da importanti aziende nazionali e internazionali, godono dell’appoggio di poderosi servizi marketing. Come possono le piccole e medie aziende italiane competere in campo di branding?
Penso che questo particolare periodo debba essere visto come un’opportunità, per la realtà italiana. Oggi è condiviso a livello mondiale un rilevante luogo comune: l’italiano viene spesso additato come poco professionale o non affidabile, ma l’italianità è un valore indiscusso. Probabilmente questo gap tra italiano e italianità è stato compreso di più dagli stranieri che da noi. Dobbiamo trovare il modo migliore per vendere il “Made in Italy”. Noi crediamo che l’italiano sia riconosciuto solo per la sua capacità creativa, la sua fantasia, il suo estro. Certo, queste caratteristiche fanno parte del nostro Dna e ci vengono ampiamente riconosciute, ma a volte, non ci rendiamo conto che siamo apprezzati anche per altro, come la tecnologia o la capacità di sviluppare innovazione.
Allora, come possono le cosiddette Pmi inserirsi in questo discorso di branding?
Intanto prendendo coscienza, come dicevo prima, che l’italianità è un plus enorme, e in secondo luogo pensando di esportare il proprio know-how. Quello che possono fare queste realtà, rispetto ai grandi gruppi, è sfruttare la propria agilità, la flessibilità e la capacità di agire in tempo reale. Infatti, a differenza del passato - quando si pianificava un budget industriale su cinque o dieci anni -, ora tutto avviene in modo estremamente veloce e occorre adattarsi con rapidità ai cambiamenti. Le piccole e medie imprese, proprio perché non hanno un grande potere economico, hanno pertanto le carte in regola per operare con successo attraverso una strategia di branding, forse oggi l’ultima frontiera del fare business in Italia e nel mondo.
Per una media azienda italiana qual è l'approccio migliore per iniziare una valida politica di marca?
Una start-up gode spesso di più libertà nell’operare determinate scelte, rispetto a realtà esistenti che devono evolvere la propria mentalità su un visssuto radicato. Un’azienda esordiente, dopo avere creato i suoi prodotti, deve analizzare in anticipo i punti di forza e di debolezza del business proposto, al fine di rendere alcune criticità non lesive nel tempo. Dopo di che è importante imparare che cosa vuol dire operare con una strategia di branding. Oggi, quando un’azienda vende un prodotto, deve anche vendere il suo marchio. Come si fa? Attraverso il nostro lavoro si vuole trasferire un know-how, insegnare come proporre un brand, far capire che cosa significa gestire un marchio e, da un punto vista economico/finanziario, definire una strategia per la sua capitalizzazione. In questo modo ogni investimento potrà confluire nel valore del marchio e, come diciamo noi, diventare marca.
Il consumatore è più informato e attento di un tempo. In che modo le aziende devono aggiornare le loro politiche di branding?
Come ogni individuo, in qualche modo, deve rendersi conto del periodo storico che sta vivendo, così una marca deve trovare un proprio modo di essere in grado di evocare un’identità al passo con i tempi. Questo non significa che deve cambiare, anzi. L’ultima cosa da fare è seguire le mode e immaginare che cosa vuole il consumatore. Un brand deve pensare, invece, a costruire una propria personalità, originale, senza preoccuparsi di quello che idealmente il cliente vorrebbe. Deve porsi al di sopra di come il consumatore vive in questo momento particolare. Un prodotto di marca deve farci sognare o farci stare meglio. In pratica, quando si va a creare un brand, si devono ridurre ai minimi termini i condizionamenti, pur senza essere avulsi dalla realtà.
Quali sono secondo lei i driver di una reputazione di marca in chiave social?
Credo che non si debba a tutti i costi essere su Facebook, anche se non possiamo ignorare i social network, che oggi vanno considerati come normali media. Il problema vero delle aziende è comprendere che rispetto al passato non si ha più il controllo dell’informazione, perché tante sono le fonti alle quali il consumatore si riferisce - dal telefonino alla tv, dai poster digitali alle piattaforme di condivisione - e con Internet il classico “ricevente” diventa oggi “emittente”. Questo rende sicuramente tutto più complesso e spesso destabilizzante. Oggi si confondono i diversi piani, la realtà con la virtualità. Internet e altri cosiddetti nuovi media alimentano questa confusione senza considerare che le aziende, le persone e gli stessi prodotti che ci stanno dentro, sono reali e non cambiano perché vengono proposti attraverso uno strumento digitale. Il fatto è che, utilizzando questi mezzi, l’opinione pubblica può condizionare l’idea di un brand e quindi l’azienda deve solo capire che non può più lanciare un messaggio senza valutare l’impatto che può avere nel tempo. Un comunicato stampa può essere letto o interpretato in modi inaspettati, da dispositivo di notorietà può anche trasformarsi in lesivo per una marca. Per il mondo delle imprese avere la consapevolezza di non poter controllare le sue informazioni in uscita è molto importante. Lo stesso concetto di media mix di un tempo viene sovvertito, anche se certi mezzi sono più idonei di altri per raggiungere un determinato cluster. Quello che conta è non solo concentrarsi sul messaggio da dare, ma rimanere fedeli a chi si è, al proprio vissuto e al proprio posizionamento. Oggi per essere efficaci in comunicazione non bisogna solo parlare, ma evocare.
Intervista di Roberto Nucci, tratta da Mediaforum - dicembre 2012.








